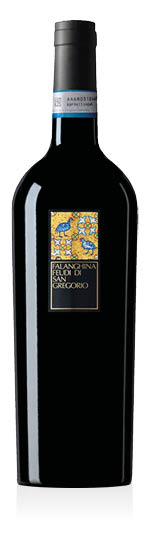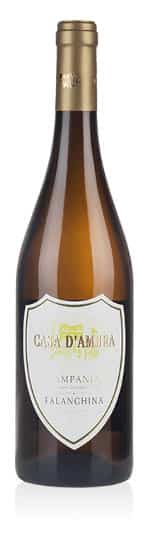Falanghina, Campania
Il vitigno Falanghina è originario della Campania, regione in cui occupa una discreta porzione dell’intera superficie vitata. Tuttavia, la sua diffusione si estende anche ad altre regioni meridionali della Penisola. La probabile origine del nome è forse da rintracciare nei pali di sostegno detti falanghe, necessari ad accogliere lo sviluppo vegetativo della pianta. Risparmiato dalla fillossera, il vitigno Falanghina ha riscontrato negli ultimi decenni un notevole successo e spesso è allevato a piede franco. La zona campana di maggior diffusione riguarda la provincia di Caserta, la zona del Sannio e la zona dei Campi Flegrei. Dal punto di vista geografico si tratta di zone climaticamente molto distinte. Il Falanghina Campi Flegrei è diffuso nella parte settentrionale del Golfo di Napoli con un’estensione occidentale fino all’isola di Procida: grande mineralità e aromi primari floreali e fruttati sono i caratteri che contraddistinguono la Falanghina prodotta nella DOC Campi Flegrei in cui si tende a preservare l’immediatezza dei sentori primari restituendo un vino diretto e piacevole. Molto più estesa è la zona del Sannio che comprende le sottozone Taburno, Solopaca, Sant’Agata dei Goti, Guardiolo: l’entroterra collinare distribuito tra le province di Benevento e Avellino è delimitato a ovest dal Monte Taburno con terreni argillosi e marnosi che conoscono un clima asciutto in estate e godono di un’esposizione molto favorevole. Alla provincia di Caserta deve essere invece riferito il successo del vinum album Phalanginum un vino bianco a base di Falanghina da cui si produceva in epoca romana anche il Falerno bianco, riproposto ancora oggi nella zona di Falciano del Massico. Nel tempo il Falanghina ha conosciuto un progressivo affinamento in termini qualitativi guidato dalla volontà dei produttori di esaltare del vitigno vinificato in purezza fino a portarlo al successo del Fiano e del Greco. Al di fuori delle aree menzionate, l’inserimento del Falanghina nella provincia di Avellino con il Falanghina Irpinia Dop è abbastanza recente. Il Falanghina si adatta bene al clima caldo e secco e consente la produzione di vini freschi e mediamente aromatici, spesso vinificati in acciaio e con eventuale sosta sui lieviti per garantire la conservazione degli aromi floreali e fruttati tipici del vitigno. La prossimità dei vigneti a zone vulcaniche, tanto nel beneventano come nella provincia di Caserta, garantisce la conservazione di una piacevole mineralità ben bilanciata da un corpo di grande morbidezza e da grande compostezza sul piano organolettico.
Acquistare Falanghina online
Una volta riconosciute le tipologie di Falanghina disponibili sulla nostra enoteca, acquistare Falanghina online sarà facile e divertente. Potrai utilizzare i filtri di ricerca per orientarti nell’acquisto di Falanghina e dedicare la tua ricerca al tipico Falanghina del Sannio, senz’altro il più diffuso. Potrai, inoltre, conoscere da vicino la complessità di un vino più esigente e meno diffuso come l’Irpinia DOC che in casi particolari si avvale di un breve affinamento in botte per regalare più corpo e morbidezza oltre a sottili sentori di spezie bianche e note di miele.
Qual è il miglior Falanghina?
Difficile stabilire quale sia il miglior Falanghina tra tante etichette distinte per provenienza e lavorazione. In linea di massima e con le dovute precisazioni, potrai assaggiare vini più minerali e leggeri provenienti dalla costa, mentre le denominazioni riguardanti il beneventano conservano maggior struttura e corpo, con un ventaglio aromatico più definito e riconoscibile.
Da quale regione proviene il Falanghina?
Il Falanghina proviene originariamente dalla Campania anche se la sua diffusione copre anche Puglia, Molise, Lazio e Calabria.
Dove trovare un Falanghina frizzante?
Molte aziende hanno deciso recentemente di utilizzare i metodi Charmat e Classico per spumantizzare il Falanghina ottenendo risultati sorprendentemente interessanti. Rispetto alla rifermentazione naturale in bottiglia tipica dei vini cosiddetti ‘frizzanti’, in questi casi la seconda fermentazione è indotta con l’aggiunta di lieviti.
 Il vino campano ha una antichissima tradizione vitivinicola, uno tra i primi territori al mondo ad aver visto l’insediamento, la coltivazione, lo studio della vite e la produzione di vino. La diffusione della vite, infatti, risale all’epoca pre-romana, grazie soprattutto a un clima particolarmente favorevole e alla particolare natura del suolo, e in epoca romana uno dei vini più pregiati era il Falerno.
Il vino campano ha una antichissima tradizione vitivinicola, uno tra i primi territori al mondo ad aver visto l’insediamento, la coltivazione, lo studio della vite e la produzione di vino. La diffusione della vite, infatti, risale all’epoca pre-romana, grazie soprattutto a un clima particolarmente favorevole e alla particolare natura del suolo, e in epoca romana uno dei vini più pregiati era il Falerno.
Questa regione presenta un ricco patrimonio di uve di grande qualità, che danno vita a un’ampia varietà di vini, sia bianchi che rossi, tra cui tante eccellenze, molto note e apprezzate non solo in Italia, ma anche all’estero, con un totale di 4 vini DOCG, 15 Vini DOC e 10 Vini IGT divisi in 5 macrozone: il Casertano, l'area di Napoli e le splendide isole di Capri e Ischia, l'Irpinia, il Beneventano. Ovunque nella regione la composizione dei terreni è legata alle eruzioni del Vesuvio, la cui attività vulcanica ha disperso notevoli quantità di ceneri anche a lunghe distanze, arricchendo la terra di componenti minerali.
Vino rosso campano
Il vino rosso campano più diffuso è l’Aglianico, al quale si uniscono il Piedirosso (detto Per’e Palummo, ossia Piede di Colombo), lo Sciascinoso, il Pallagrello nero e il Casavecchia, quest’ultimo dimenticato per anni e recentemente riscoperto con ottimi risultati e vini di estrema eleganza e riccamente colorati. I due vini rossi DOCG campani, Taurasi e Aglianico del Taburno vedono entrambi come protagonista il vitigno Aglianico. Il Taurasi, che affina per almeno tre anni in botte, è molto strutturato e adatto a lunghi invecchiamenti, tale che la sua longevità può essere paragonata a quella dei grandi rossi italiani come Brunello o Barolo. L’Aglianico rientra anche nei vitigni della denominazione Campi Flegrei, dove è molto diffuso anche il Per ‘e Palummo (piede di colombo), che deve il suo nome alle nodose basi rosse dei ceppi delle viti, simili ai piedi rossi di un colombo e regala vini succosi, intensi e piacevolmente fruttati. Entrambi questi vitigni sono diffusi anche nella denominazione Costa d’Amalfi e nelle denominazioni Falerno del Massico DOC e Irpinia DOC. Da non dimenticare poi altri vitigni rossi minori come il Casavecchia, il Pallagrello nero e lo Sciascinoso.
Vino bianco campano
Il più antico vino bianco campano è il Falerno del Massico, che veniva prodotto dal vitigno Aminea Gemina, oggi conosciuto come Greco, ed era conosciuto e apprezzato in tutta l’antica Roma. Oggi il Greco resta uno dei vitigni più importanti della Campania e dà vita, tra gli altri, ad un bianco DOCG perfetto per i piatti di pesce e per i formaggi freschi. L’altro grande bianco campano è il Fiano di Avellino, protagonista nell’omonimo vino DOCG, che si caratterizza per sapidità e freschezza ed era uno dei vini preferiti di Federico II di Svevia. Meno prestigiosa ma apprezzatissima in tutta Italia è la Falanghina, interessantissima nella zona dei Campi Flegrei e che dà ottimi risultati anche come spumante metodo classico e il cui nome sarebbe da far derivare dalle "falange" i pali che, sin dall’antichità, venivano usati per sostenerne le viti. Altri vitigni minori sono il Coda di volpe, che fa parte della leggendaria denominazione Lacryma Christi, il Palagrello e l’Asprinio. Da non dimenticare, infine, i bianchi nati e cresciuti sull’isola di Ischia come il Forastera e il Biancolella di Ischia che nascono da viticoltura eroica, da vigneti aggrappati alla terra e affacciati su alcuni dei panorami più belli del mondo.
Quanti sono i vini campani docg?
Esistono in tutto quattro vini campani docg, due bianchi e due rossi.
Quali sono i principali produttori di vini pregiati campani?
Ci sono molti produttori di vini pregiati campani, tra i più famosi troviamo sicuramente Feudi di San Gregorio, Mastroberardino, Marisa Cuomo e Quintodecimo.
Perché si parla di vini vulcanici in Campania?
I vini vulcanici in Campania nascono alle pendici del Vesuvio e si arricchiscono di piacevolissime note minerali: un eccellente esempio ne è la Falanghina dei Campi Flegrei.